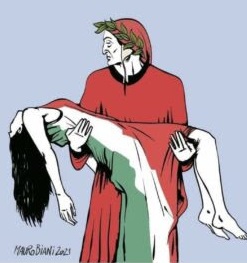Nel silenzio spesso complice dell’informazione ufficiale, il glifosato — l’erbicida più utilizzato al mondo — continua a insinuarsi nella nostra catena alimentare, nell’acqua che beviamo e nell’aria che respiriamo, eppure i dati più recenti, provenienti da studi sperimentali e ricerche epidemiologiche, confermano i rischi per la salute legati all’esposizione al glifosato.
In particolare, dallo studio dell’Istituto Ramazzini, pubblicato sulla rivista Environmental Health: l’esposizione cronica al glifosato, iniziata in utero e protratta per due anni in ratti di laboratorio, ha provocato un aumento significativo e dose-dipendente di tumori multipli: leucemie precoci, tumori del sistema nervoso, della pelle, del fegato, delle ossa e della tiroide.
Ma i rischi non si fermano qui. Studi recenti suggeriscono che il glifosato possa contribuire anche allo sviluppo di malattie neurologiche complesse, come l’autismo e il morbo di Parkinson, agendo come co-fattore ambientale in soggetti geneticamente predisposti, danneggiando il sistema nervoso fin dalle prime fasi della vita. Inoltre, il glifosato altera profondamente il microbiota intestinale, influenzando l’equilibrio tra cervello e intestino e contribuendo a stati infiammatori cronici e stress ossidativo.
La questione, oggi, non è più se il glifosato sia pericoloso. La vera domanda è: perché le istituzioni politiche e sanitarie locali continuano a tollerarne l’utilizzo in ambiti così sensibili — come parchi pubblici, giardini scolastici e aree verdi urbane — pur conoscendone la tossicità documentata?